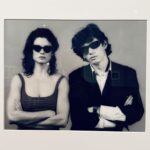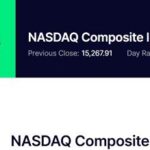L’amore: dalle Lupercalie ai nostri giorni

San Valentino è un Santo italiano. Egli nacque a Terni, in Umbria, da una nobile famiglia. Convertito al cristianesimo, si trasferì a Roma ove, con fervore, celebrava segretamente matrimoni nella fede cristiana. Era l’epoca in cui la Roma pagana perseguitava la nuova dottrina e i suoi seguaci. Fu questo il clima dell’Urbe che accolse il fervente credente cristiano. La Chiesa lo ricorda soprattutto per il suo ardore nell’unire coppie di innamorati nel rito cristiano, nella Roma dell’imperatore Claudio. Ben presto, però, l’attività segreta di Valentino determinò il suo arresto e conseguenti indicibili torture affinché rinunciasse al suo credo religioso. Valentino non abiurò, affrontò il suo martirio il 14 febbraio del 268 d.C e fu canonizzato. Nel quinto secolo d. C., due secoli dopo la morte del Santo, le autorità religiose cristiane ancora si confrontavano con vecchie e radicate celebrazioni pagane, tra cui le Lupercalie. Non riuscendo ad estirpare dalla mente e dai cuori la tradizione pagana dell’amore ricordata dall’antica ricorrenza, urgeva assolutamente ricorrere ai ripari attraverso il solito ed eterno sincretismo religioso; operazione non nuova nella Chiesa cristiana. Fu Papa Gelasio I, Pontefice dal 492 al 496 d. C., che nel gennaio del 495 soppresse le Lupercalie e il culto di Luperculus, dio italico dell’amore, della fertilità e della purezza; attributi che furono trasferiti di sana pianta alla Vergine Maria. In quanto al nume, questi venne sostituito con S. Valentino, martire dell’amore coniugale; di qui l’estensione del dominio del Santo anche a protettore dei giovani amanti e dell’amore dei nostri giorni. Ma in cosa consistevano le Lupercalie? Come venivano celebrate? Era una festività annuale delle genti italiche osco-sabelliche, pervenutaci dalla Roma romulea. Con esse veniva celebrato annualmente il Dio pagano Luperculus, il 13, 14 e 15 febbraio. Si trattava di un rituale propiziatorio e di purificazione in previsione di marzo, inizio dell’anno romuleo. Un rituale che preparava alla primavera, motivo per cui veniva celebrato l’amore, la fertilità e la purezza. Da notare che febbraio era il mese della Dea Febris, divinità della purificazione per eccellenza, del “puro amore”; la “Febbre che arde nei petti”. Interessante notare, inoltre, che la nostra parola febbre risale proprio da Febris, divinità che “ardeva d’amor”. Curioso che fino ad un recente passato la febbre era considerata l’effetto di una purificazione del fisico visto che la febbre purificava l’organismo dalle tossine accumulate durante la stagione invernale, e lo preparavano, in certo qual modo, alla rinascita. I sacerdoti delle Lupercalie, i Luperci, officiavano il rito nel Lupercale che, secondo Ovidio e Plutarco, deriva dal nome dalla lupa che avrebbe allattato Romolo e Remo in una grotta chiamata, appunto, Lupercale. Puntualmente, alle idi di febbraio, come ci informano i calendari romani giunti fino a noi e secondo Plutarco (Rom., 21, 4-10), ogni anno i Luperci sacrificavano nel Lupercale alcune capre ed un cane alla presenza del flamen Dialis. Finito il sacrificio e tagliate in strisce le pelli delle capre sacrificate, i Luperci iniziavano la loro corsa attorno al Palatino brandendo una o più strisce di pelle caprina, chiamate februae (purificatrici), che usavano per battere chiunque incontrassero sulla loro strada. Alle frustate rituali dei Luperci, oltre alla purificazione, era attribuita una funzione fecondativa. Seguiva il “purificatio fascis”: le stesse strisce, ancora rosse di sangue, sostituivano i legami che serravano i Fasci, costituiti da dodici verghe con scure. Nel segno di AMOR (Roma) venivano rinnovati i fasti romani. Venere, Dea dell’amore, era, insieme a Marte, il nume tutelare di Roma e a capo della gens Julia. Oltre ad essere un rituale che ricordava Romolo e Remo salvati dalle acque del Tevere e allattati da una lupa, il Lupercale riporta anche al culto di Fauno Luperco e alla dea Fauna, ossia Luperca. Come si può constatare, la celebrazione dell’amore costituisce una delle manifestazioni più antiche e radicate nel profondo di ogni essere umano, nato dall’AMORE e con l’AMORE. Per gli iniziati questo termine era l’anagramma: “senza la morte”, cioè vita senza la morte (la A di A-MOR come ablativo). Sin dalla preistoria, l’amore è stato considerato il più potente dei moventi della vita manifestata. È la legge che tutto “muove”: dall’attrazione biologica sessuale al fascino romantico, alla spiritualità dei mistici e dei Santi, alla poesia cortese dell’“AMOR che move il sol e l’altre stelle” di Dante, e dei “ Fedeli d’Amore”. L’amore è un fascino, una forza misteriosa e irresistibile che ogni essere, dal più elementare al più complesso, sente palpitare nel suo intimo. A livello umano, è un “fuoco” che arde e consuma (morir d’amor) chiunque brucia di desiderio, nella brama non sopita, di un congiungimento con “l’anima gemella”. A livello spirituale, è l’AMORE che differenzia l’umanità da tutti gli altri esseri manifestati. Nell’essere umano, l’amore è la fiamma che appaga e armonizza quando appagata da uno “stato di pienezza”. Qui il senso recondito della frase virgiliana: “Omnia vincit Amor”.