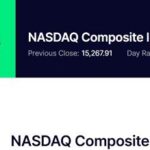I venti di guerra, che ormai da giorni soffiano sull’Ucraina, e le conseguenti sanzioni economiche imposte alla Russia di Vladimir Putin fanno infiammare i prezzi delle materie prime, da quelle energetiche come gas e petrolio, che alimentano il “caro bollette” e il “caro benzina”, fino a quelle alimentari, che rendono più oneroso l’acquisto di beni di prima necessità come pane e pasta.
Infatti, i rincari record delle materie prime energetiche e agricole si devono a tanti fattori ma le ripercussioni sono diventate ormai evidenti anche ai consumatori finali, dopo diversi mesi di incremento “silenzioso”.
Poche settimane fa l’agroalimentare italiano festeggiava il superamento dello storico traguardo di 50 miliardi di euro di export e ora deve fare i conti non solo con l’aumento dei costi di produzione, ma anche con il conflitto tra Russia e Ucraina.
Lo scoppio del conflitto si è inserito in un contesto di tensioni sui mercati dei cereali che non si vedeva dalla precedente crisi dei prezzi del 2007-2008. Queste tensioni vedono l’Italia particolarmente vulnerabile a causa della sua dipendenza dall’estero proprio per gli approvvigionamenti di grano e mais con i quali si fanno le nostre paste e i nostri biscotti o con i quali si nutre il bestiame.
Dalle più recenti analisi effettuate dopo lo scoppio delle ostilità, risulta che frumento tenero, frumento duro e mais hanno raggiunto, sia in Italia che all’estero, quotazioni mai toccate prima. Non tutto però è riconducibile direttamente alla guerra, che certamente ha aggravato soprattutto le dinamiche alla base della fiammata che varia a seconda del prodotto.
Il grano duro, per esempio, aveva già raggiunto il suo prezzo massimo a dicembre 2021. In questo caso, l’instabilità era stata determinata principalmente dal vuoto d’offerta che si era creato dopo il crollo dei raccolti in Canada (-60%), principale esportatore mondiale e il calo registrato da altri importanti Paesi produttori. Nelle forniture globali di grano duro, il ruolo del conflitto fra Russia e Ucraina sembra praticamente inesistente, visto che la produzione è concentrata in Europa, Canada, Usa, Turchia e Algeria.
Tuttavia non si può non tenere conto che Russia e Ucraina sono i più grandi esportatori mondiali di grano (insieme rappresentano circa il 30% delle esportazioni globali), di mais (circa il 20%) e di olio di semi (per quasi l’80%). È vero che l’Italia, per quanto riguarda ad esempio il grano, produce il 65% circa del fabbisogno destinato al mercato interno, ma per il restante 35% dipende proprio dai paesi coinvolti in questa crisi politica.
A questo punto non è difficile prevedere che a breve, e in qualche caso addirittura in brevissimo tempo, assisteremo ad un diffuso aumento dei prezzi di pane e pasta, che in Italia rappresentano una gran parte dei consumi alimentari quotidiani. Basti pensare che il consumo pro capite di pasta sfiora i 25 chili l’anno fra i cittadini italiani.
Inoltre, il rincaro di altri prodotti che l’Italia importa dai paesi coinvolti nel conflitto, come il mais e le farine di cereali o soia, utilizzate prevalentemente per l’allevamento degli animali, non potranno che incidere negativamente sulla formazione del prezzo finale per i consumatori.
Dunque, carni, latte e derivati finiranno per costare inevitabilmente un po’di più nel medio e lungo periodo. Fra gli addetti ai lavori si parla della necessità di trovare nella crisi un’opportunità. Questa va ricercata necessariamente in una maggiore indipendenza alimentare italiana esattamente come il Paese sta cercando una maggiore indipendenza energetica grazie ai recenti provvedimenti che il governo ha adottato e continua a adottare.
La guerra, incidendo sulle notevoli importazioni di cereali da Russia e Ucraina porta ad una riduzione degli approvvigionamenti e a un aumento dei prezzi e, di conseguenza, suggerisce la necessità di diventare più autosufficienti da questo punto di vista, dato che i terreni agricoli per coltivare cereali nel Bel Paese certo non mancano. Ciò non solo per non dipendere dall’estero, almeno dal punto di vista alimentare, ma anche per produrre prodotti tipici realmente italiani e non solo “lavorati” in Italia, con la pretesa paradossale poi di proteggere il Made in Italy.